Lo disse il Telegiornale del Nazionale, quello del pranzo, e noi piccoli milanisti capimmo benissimo. Guarda, sembra che è morto suo nonno, sibilò il padre interista, e con sua buona pace sì, era proprio così, perché aveva la faccia da nonno simpatico e perché anche in quei primissimi anni di catechismo rossonero era proprio impossibile non sapere che Nereo Rocco era il “capo del Milan”, era il Milan.
Ma come, proprio adesso che stiamo vincendo lo scudetto. E quale scudetto, poi: la Stella. 
In realtà quello lì, 20 febbraio 1979, era un momento di scricchiolii, dopo un girone di andata formidabile un pezzo di lingua stava fuoriuscendo dalla bocca. Due giorni prima, a San Siro, un deludente pareggio con l’Atalanta con un piede in B, inutile il gol di Bigon. La settimana prima, contro il pericolante Ascoli, c’era voluto un miracolo balistico dell’Aldone Maldera per portarla a casa. Abbastanza per preoccuparsi, o smoccolare, ma il Paròn non poteva più farlo. Entrato in ospedale a Trieste il martedì 13, non ne sarebbe più uscito. Una impietosa foto pubblicata dalla Gazzetta il giorno seguente la scomparsa lo ritraeva nel suo lettino d’ospedale, gli occhi socchiusi, l’immagine della sofferenza.
“Tito dame el tempo”, le ultime parole al figlio prima di scivolare nel buio, mentre fuori, a Trieste, c’era una luce che spaccava, il sole totalmente smarcato dalla bora. 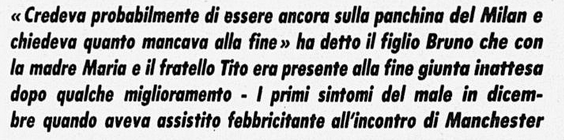 Le ultime parole al suo Milan, invece, le aveva rivolte un paio di settimane prima, nella persona del direttore sportivo Sandro Vitali: anche da lontano, aveva capito la sopravvenuta difficoltà e disse di riferire ai “muli” di non mollare, che la Stella era lì, vicina, molto più vicina degli anni – tre in fila – in cui l’aveva sfiorata lui, fottuto prima dall’Inter nel ‘71, e quindi dalla Juve nel ‘72 e ‘73, col finale osceno del 5-3 a Verona, giorno del suo 61.o compleanno. Fottuto sul serio, con porcate arbitrali contro ancora insuperate nella lunga storia del Diavolo, e stavolta la speranza poteva nascere anche dal fatto che Madama era distante, fuori tiro: la minaccia veniva da Perugia, non si poteva perderla ancora.
Le ultime parole al suo Milan, invece, le aveva rivolte un paio di settimane prima, nella persona del direttore sportivo Sandro Vitali: anche da lontano, aveva capito la sopravvenuta difficoltà e disse di riferire ai “muli” di non mollare, che la Stella era lì, vicina, molto più vicina degli anni – tre in fila – in cui l’aveva sfiorata lui, fottuto prima dall’Inter nel ‘71, e quindi dalla Juve nel ‘72 e ‘73, col finale osceno del 5-3 a Verona, giorno del suo 61.o compleanno. Fottuto sul serio, con porcate arbitrali contro ancora insuperate nella lunga storia del Diavolo, e stavolta la speranza poteva nascere anche dal fatto che Madama era distante, fuori tiro: la minaccia veniva da Perugia, non si poteva perderla ancora.
Ci teneva da matti alla Stella il Paròn, era il cruccio, l’ultimo tratto di penna che serve a completare la figura coi puntini. Cominciò a dirlo una sera del ‘69, in studio alla Domenica Sportiva con la Coppa Intercontinentale, “me manca quella e poi mi piacerebbe riportare la Triestina o il Padova, le mie squadre, in Serie A”.  E invece, fatta eccezione per l’esilio fiorentino, ci sarebbero stato solo il Milan e una rincorsa sempre più vana e quasi utopica, il declino del club, gli alti e bassi personali con la rottura con Buticchi prima e il rientro più o meno in gloria da direttore tecnico, con Rivera padrone sui generis.
E invece, fatta eccezione per l’esilio fiorentino, ci sarebbero stato solo il Milan e una rincorsa sempre più vana e quasi utopica, il declino del club, gli alti e bassi personali con la rottura con Buticchi prima e il rientro più o meno in gloria da direttore tecnico, con Rivera padrone sui generis.
Già, Rivera. Era in montagna a Courmayeur, due giorni di vacanza per pausa di campionato, insieme a compagna (Elisabetta Viviani), figlioletta e presidente (Felice Colombo), quando gli arrivò la telefonata dalla sede, la Rina Ercoli dall’altro capo del telefono. Colpito e affondato, sapeva della gravità, non immaginava una fine così repentina.
L’uomo non era e non è da lacrime, ma la perdita era enorme e lo mise nero su bianco in una lettera pubblicata sulla Gazzetta il giorno dei funerali. “In questi giorni mi passano davanti agli occhi tanti ricordi dei giorni che abbiamo vissuto insieme. Quando credo di trovare quello più bello, subito mi accorgo di sbagliare. Adesso dovrò abituarmi a fare a meno di lei, è sarà dura, ne sono convinto. Vuol dire che con i miei compagni cercherò ancora di più di conquistare quella Stella alla quale lei teneva tanto. Quella Stella le appartiene e noi faremo di tutto per regalargliela”. 
Rivera che porta a spalla il feretro, dall’altra parte Nino Benvenuti, dietro Benvenuti, Bigon. Tra i tanti venuti a Trieste a dirgli addio i suoi ex ragazzi, molti dei quali, non a caso, allenatori: Trapattoni, Cesarone Maldini, Gigi Radice, Giacomini, Capello. Poi la vecchia e la nuova guardia: Schnellinger e Rosato, Albertosi e Liedholm, il ragazzino Franco Baresi e Giovanni Sartori, più fortunato come dirigente. Dentro la bara, il Paròn vestito con la divisa del Milan: “Sì, gli metto questa, sono sicura che è quella che lui avrebbe scelto”, disse la moglie nella casa di Via D’Angeli ai cronisti il giorno prima. Sperduta, piegata, ma non spezzata la Siora Maria, protagonista di mille battute di Rocco o all’Assassino. “Perché no zoghi? Xe sta un’idea de mia moglie”, sbottò un giorno a un escluso, tanto per fare un esempio.  Robe che ora finivano nel libro dei ricordi belli, insieme alle foto, alle immagini, lui a Milanello con in braccio la Campioni e la Intercontinentale come fossero sue bambine.
Robe che ora finivano nel libro dei ricordi belli, insieme alle foto, alle immagini, lui a Milanello con in braccio la Campioni e la Intercontinentale come fossero sue bambine.
Rimanevano il dolore e un vuoto che una squadra molto giovane, che aveva incrociato solo al crepuscolo il Paròn e dunque non ne era stata forgiata, non avrebbe forse sentito al punto da farne uno stimolo, un trampolino per il traguardo come nei desideri di Rivera. Ma ci sarebbe stato ancora bisogno di lui, di Nereo Rocco, del suo aiuto da un altro posto, con gli occhi protetti dalla mano sulla testa del cappello e gli occhi, appunto, sempre e solo sul suo Milan.